La passione per la Psicosomatica inizia presto
Mi laureo in Medicina e Chirurgia alla Statale di Milano (summa cum laude), con la tesi ‘‘L’ansia e i meccanismi intrapsichici e intrasomatici nella patologia della personalità’’.
Per anni prima della laurea e nell’anno post laurea sono interna presso la Clinica psichiatrica universitaria, dove, con una ricerca principalmente clinica, raccolgo i dati per la tesi. Ma non voglio convogliare subito nella psichiatria e nella psicoanalisi: non esiste ancora la specialità in medicina Interna, mi specializzo in pediatria con 70/70 e lode e una tesi sulle patologie autoimmuni, considerate le malattie ponte per eccellenza tra psiche e soma. Dall’inizio, dai miei studi universitari, comincio a occuparmi così del cosiddetto MB problem, (l’eterno) problema mente corpo.
Le analisi
Mentre lavoro in pediatria alla clinica universitaria milanese De Marchi, inizio un’analisi personale che dura 7 anni, a 4 sedute settimanali, a Milano. Ragioni personali e familiari mi portano poi a intraprendere una seconda analisi, ben più breve, a Ginevra.
Diventare psicoanalista
Tra gli anni ‘80 e ‘90, come candidata della Società di psicoanalisi Svizzera, a Ginevra (al centro Raymond de Saussure) e a Lugano (al centro psicoanalitico diretto allora da PierMario Masciangelo), seguo lezioni, seminari, lavori di gruppo; a Ginevra e a Milano ho esperti psicoanalisti supervisori del mio lavoro clinico; ho supervisioni (di gruppo) anche a Londra e a Parigi; faccio parte di gruppi teorico-clinici diretti da psicoanalisti quali René Diatkine, punto di riferimento umano e professionale (ho lavorato con lui sul tema del ‘sogno’ e delle ‘psicosi’, per 8 anni).
I maestri
Uno dei maestri, Renée Diatkine.
Nato a Parigi, di origini russe, inizia a lavorare come psichiatra all’Ospedale parigino Sainte-Anne e fa una sua analisi personale con J. Lacan (E una seconda analisi con un altro importante analista, Nacht).
Una volta analizzato da Lacan, a sua volta ha in analisi il filosofo Louis Althusser ...
Presidente della Società psicoanalitica di Parigi, è uno dei fautori di quella psicoanalisi “medicalizzata”, legata alla psichiatria, in rottura con il pensiero di Lacan. Dedicandosi totalmente all’infanzia, diventa uno dei più importanti psicoanalisti infantili al mondo.
Dai suoi seminari imparo la psicoanalisi intesa come “fortissima, eterna capacità di fantasticare’’, eppur legata strettamente alla medicina.
Entrare nella società internazionale di psicoanalisi (IPA)
A Berna, con un lavoro poi pubblicato: “Una fobia della lucertola”, ottengo il titolo di full member della Società di Psicoanalisi Svizzera, (SSP), che fa parte dell’International Psychoanalytical Society (IPA).
Entrare a pieno titolo in una piccola, antica, prestigiosa istituzione fondata da un genio quale è Freud (neuroscienziato, inventore della psicoanalisi, premio Nobel per la letteratura!) è una svolta.
Nel lavoro sulla ‘fobia’ metto insieme dati psicoanalitici e medici, le due lingue ... E l’interesse nel ‘bilinguismo’ si approfondisce.
Con un altro lavoro, presentato anni dopo al centro milanese Cesare Musatti, ottengo la dual membership nella Società di Psicoanalisi Italiana (SPI).
Questo cammino di grande investimento, curiosità, passione, dura quasi 20 anni.
La parte più interessante dell’intero iter psicoanalitico
Dal primo congresso della Federazione Europea di Psicoanalisi (FEP), a Praga, nel 2002, partecipo ogni anno per 12 anni, nei vari congressi europei, a un gruppo teorico clinico diretto da una nota psicoanalista francese di origini argentine, Haidée Faimberg. Vuol dire immergersi molte ore al giorno per più giorni con psicoanalisti provenienti dai paesi più disparati e di madre lingua diversa, in un confronto teorico clinico basato sull’ascolto, alla ricerca di una sola cosa: trovare una base comune (Common ground) con cui lavorare nella clinica. Il fatto straordinario è che ascoltando sul serio e a lungo, -immergendosi a lungo nell’ascolto reciproco-, nonostante le diversità, succede di trovare quasi sempre una vera base comune.
La Psicosomatica
Negli stessi anni mi formo come Psicosomatista attraverso varie esperienze, sia in ambito medico, nella medicina Psicosomatica, con gruppi di medici ricercatori e in numerosi corsi e convegni, sia nell’ambito della Psicosomatica Psicoanalitica, principalmente alla scuola del canadese Graeme J. Taylor, psichiatra, psicoanalista e psicosomatista di riconosciuto valore, che insieme ad altri studiosi ha approfondito il campo della alexitimia, creando utili strumenti di indagine.
Il lavoro, le pubblicazioni, la partecipazione alla politica societaria
Lavoro da subito come psicoanalista e psicosomatista in privato.
Insegno in diverse scuole di Psicoterapia in Italia, e al centro milanese di psicoanalisi Cesare Musatti tengo lezioni agli studenti sulla Psicoanalisi Francese e sulla Psicosomatica. Al centro stesso e in altri ambiti per anni ho conferenze aperte al pubblico sulla Psicosomatica.
Sono supervisore in campo psicosomatico, privatamente, e in istituzioni.
Svolgo seminari in istituzioni pubbliche e private. Un seminario che ricordo con un gusto particolare, nel giugno del 2015, è all’Ospedale San Paolo di Milano, in psichiatria: “Ripensare mente corpo inconscio: l’attitudine ingenua a trattare il problema mente-corpo con il trattino”.
Dei contratti universitari, ricordo con interesse quello a Torino, a Psicologia Clinica, alla Scuola di Specialità diretta allora da F. Borgogno.
Sono responsabile della conduzione di un certo numero di gruppi, in Psicoanalisi e in Psicosomatica, istituzionali e privati. Al centro milanese per esempio, nel 2014 termino dopo 9 anni un lavoro teorico-clinico con un gruppo di colleghi, su un tema a me caro “Psicoanalisi in malati organici”.
Nasce una collana di piccoli volumi, firmata per ora da autori che hanno partecipato a quel gruppo, la Collana Utopia: Il Corpo e il Senso, che inizia a uscire in Internet con un primo volume di cui sono io l’autore. Il titolo di questo primo volume coincide con il nome della collana:
Il Corpo e il Senso (Dopo la Psicosomatica).
La collana rimane aperta a ulteriori contributi.
Come, nel gruppo, lavoriamo al tema ‘Psicoanalisi in malati ‘organici’ e come, nei volumi ‘Il Corpo e il Senso’, sviluppiamo l’idea che la Psicosomatica sia nata e cresciuta all’interno di un perimetro concettuale da rivedere.
Il senso e l'intento del cammino del gruppo nei 9 anni, mentre rileggiamo e discutiamo buona parte dell’intero corpo della Psicoanalisi che si occupa di Psicosomatica, cambiano continuamente diventando relativamente chiari e condivisibili solo nel tempo. Rimane da scoprire e riscoprire insieme se il senso e l'intento a cui mano a mano approdiamo sono sufficientemente 'veri'.
Ci rendiamo conto di pensare e parlare unicamente all'interno di 'abitudini predisposte', vale a dire all’interno di operazioni, di pratiche, che sono poi le nostre tecniche, le conoscenze specialistiche nei diversi campi, le diverse esperienze, le diverse attitudini caratteriali.
E ci rendiamo conto che a volte non pensiamo affatto, ma ripetiamo slogan che confermano ‘verità’ riportate.
Per esempio, continuiamo a parlare di mente e corpo (e ambiente) come fossero enti, realtà fuori di noi realmente esistenti, di cui dobbiamo trovare l’anello di congiunzione. Quando smettiamo di cercare correlazioni tra quelli che crediamo essere erroneamente enti (la mente il corpo e l’ambiente che in quanto entità distinte si parlano, si influenzano vicendevolmente ...), capiamo sul serio di cosa si tratta: la mente non può che rimandare continuamente al corpo e all’ambiente e viceversa, e i tre ‘esistono’ per differenza l’uno dell’altro, in quanto a crearli, alternativamente, è il nostro modo di pensare e sono le traduzioni linguistiche dell’esperienza che viviamo.
Ossia essi, i tre in campo, sono solo pratiche di scrittura; modi di scrivere un’esperienza che riguarda il vivente, l’uomo; modi di contattare questo dato, l’uomo, da parte dell’uomo; e modi di provare a svolgerlo, a spiegarlo, attraverso un dispositivo alfabetico e specifici tipi di strumentazione.
Noi infine non facciamo che studiare e tradurre l’esperienza che stiamo vivendo, a vari livelli, con diverse lingue (per esempio, la medica e la psicoanalitica), che hanno le loro specificità e le reciproche incompatibilità. Diciamo che una cosa è mentale o astratta quando non la vediamo, quando non riusciamo (ancora) a identificarla con gli strumenti adatti, mentre una cosa è corporea quando la vediamo e la misuriamo. Siamo noi con il nostro bagaglio di tecniche a pensare e a dire così, non è che esistano per davvero nel mondo cose corporee e cose mentali!
Il gruppo di colleghi negli anni si propone di diventare capace, nella cura dei pazienti, di mescolare medicina e psicoanalisi, quando è utile, (lo si vedrà nel libro), per poi tornare a distinguere le due lingue. Non perché la Medicina parli di cosa è reale, e le Psicologie di cosa è fantastico e si debba trovare il modo di dar “corpo” e credibilità alle fantasie; e non perché le conquiste delle Neuroscienze confermino ciò che la Psicoanalisi dice e dunque si debba seguirle! Bensì perché queste due scienze, con i loro diversi dispositivi alfabetici e gli specifici tipi di strumentazione, descrivono ‘identicamente’ momenti di vita di esseri umani che soffrono.
La medicina fornisce dati universalmente validi, che vanno tuttavia inseriti nelle singole vite, nei vissuti soggettivi descritti dalle psicologie, con il rischio se no di indurre errori. L’accostamento delle due lingue, invece, precisa e arricchisce la diagnosi e la cura: le terapie analitiche lo confermano.
Arrivare a una verità condivisibile
Solo portando alla parola, al concetto, i vissuti profondi delle nostre 'abitudini', solo rendendoci conto insieme di quanto siamo abitati da preconcetti e verità di comodo, solo riuscendo a disfare nel tempo quelle che fino a un momento prima ci sembravano verità inoppugnabili, solo operando una decostruzione continua, arriviamo a formulare qualcosa che genera un senso per tutti, sia pure transitorio, in divenire.
Scopriamo ogni giorno che le 'abitudini' sono talmente determinate dalle circostanze della nostra vita, dall'ambiente, dalle tradizioni, dai discorsi che siamo avvezzi a fare- fattori che restano taciti, quando non oscuri nel discorso esplicito-, da concludere: proprio esse determinano il senso di verità.
Mano a mano che leggiamo e ragioniamo insieme, le ‘abitudini’ cambiano, si scovano quantità impressionanti di fake news e si creano nuovi punti di riferimento.
Nasce un nuovo senso di verità, e il grande capitolo della Psicosomatica medica e di una certa tradizione psicoanalitica rimane un faro particolarmente adatto per esplorare. Alla rincorsa delle nuove ‘certezze neuroscientifiche’ o nella sussiegosa presa di distanza (il che è lo stesso), cioè nel conformistico mare magnum delle adesioni e dei rifiuti, rimaniamo morti.
Il libro menzionato, Il Corpo e il Senso (Dopo la Psicosomatica) prova a spiegarlo diffusamente.
Le pubblicazioni più significative preparatorie al volume in uscita sono prima di tutto un vero long seller, a cui sono molto affezionata:
Peregrini C., Abraham G., Ammalarsi fa bene. (La malattia a difesa della salute). Milano: Feltrinelli, 1989.
Inoltre:
Peregrini C., & Bernetti M.G. , Cassardo C. , Marino R. , Ramella M., Simonini C., Vizziello G. P., “Vedere e immaginare: un approccio bilingue alla malattia del corpo e della mente tra medicina e psicoanalisi. Considerazioni teorico-cliniche.” 40° Congresso Società Psicoanalitica italiana, Seminari Multipli, Bologna, 2009.
Peregrini C., Cassardo C., “L’inconscio e il corpo: un’identità “disidentica”? Atti XV Congresso Nazionale Società Psicoanalitica italiana. Esplorazioni dell’inconscio, Taormina, 27-30 maggio, 2009.
Peregrini C. et al., “Corpo, Mente, e Simultaneidade” Revista De Psicanalise, vol XVII, 3: 499-526, 2010.
Peregrini C., L’Ipocondria: un campo aperto.
In: L’Ipocondria e il dubbio (V. Egidi Morpurgo; G.Civitarese (a cura di)). Milano: F.Angeli, 2011.
Peregrini C. et al., “The unconscious body (true psyche) and Dreams from the Viewpoint of Simultaneity and Double-Language”
Atti FEP 25esima Conferenza Annuale Parigi. 29 marzo- 1 aprile, 2012.
Peregrini C., "Panico, Ansie e Angoscia Ipocondriaca" Istituto Psicoterapia del Bambino e del'Adolescente Milano: Mimesis. Quaderno 36, p. 75-108, 2012.
Curo la voce Psicosomatica per Spipedia, l’enciclopedia aperta della Società Psicoanalitica Italiana (www.spiweb.it).
Ne riassumo il messaggio di fondo:
da più di cento anni siamo al lavoro insieme, psicologi, psicoanalisti, psicosomatisti, medici, in particolare neuroscienziati, per comprendere lo sviluppo del corpo mente umano studiandolo contemporaneamente a vari livelli, distinti e strettamente interconnessi, dal livello dell'organizzazione biologica, al livello del funzionamento socio culturale e psicologico.
Per decenni ci siamo occupati insieme dell'interazione tra ambiente e maturazione delle strutture organiche e delle loro funzioni. In particolare abbiamo sviluppato un modello multidimensionale della relazione ambiente/struttura/funzione per avvicinarci alla parziale comprensione dello sviluppo emotivo umano, studiando per esempio come si crea in modo interattivo e quali strutture/ funzioni influenza il legame di attaccamento tra madre e bambino, la loro comunicazione affettiva.
Adesso, a questo messaggio di fondo, aggiungerei: come potrebbe il legame di attaccamento non ‘influenzare’ queste strutture, o, meglio, come potrebbe non esserci un forte rimbalzo linguistico tra l’ambiente e le strutture/funzioni, visto che ambiente corpo e mente altro non sono che tre traduzioni linguistiche dell’esperienza (unica) che stiamo facendo? L’esperienza ‘del vivere’?.
I problemi politici
Il 13 maggio 2006, a Milano, c’è un bel convegno, denso di incontri e soprattutto di scontri:
Alle radici dell’odio. Un’analisi del fenomeno terrorismo.
Con lo psicoanalista palestinese Awad, l’israeliano Berman e lo scrittore e giornalista italiano Mario Pirani. Presento un lavoro, che porto successivamente in altre sedi e a cui tengo molto:
“Terrorismo: considerazioni psicoanalitiche” pubblicato nel Quaderno 10 del Centro Milanese di Psicoanalisi, Alle radici dell’odio.
Lo scritto nasce in anni di studi e confronti in un gruppo di colleghi condotto dalla psicoanalista Almatea Usuelli, per cercare di rispondere a domande fondamentali poste dalla Società Internazionale di Psicoanalisi , dopo l’11 settembre 2001.
E sulla base di un testo: Violence or Dialogue.
Le domande: cosa può dire la Psicoanalisi sul terrorismo?
In quanto psicoanalisti, possiamo provare a spiegare come nei terroristi, religiosi , etnici, e politici, appartenenti a gruppi guidati da leaders carismatici, la psicologia individuale sia fortemente intercorrelata a quella dei loro gruppi?
Possiamo, noi psicoanalisti, considerare e interpretare realtà che sono essenzialmente di natura sociopolititica?
Possiamo favorire la comprensione del fenomeno nella sua complessità, e diventare utili nella messa in opera di strategie difensive efficaci?
A proposito di Vero e Falso.
Dal 2000 partecipo molto più attivamente alla politica societaria, in particolare, alla modificazione delle regole statutarie, in modo di arrivare all’abolizione dell’analisi cosiddetta didattica.
Il motivo di tante battaglie, compresa questa, è attorno al solito unico tema: il Vero e il Falso.
Detto così, suona un po’ drastico e lievemente ingenuo. Sappiamo che la verità è cosa complessa, sappiamo cosa vuol dire arrivare a una verità condivisibile. Ciò non toglie che vivere nella maggiore autenticità e verità possibili porti vita, senso e forza alle cose che si fanno.
Da decenni si discute se l’analisi debba essere solo ‘personale’, motivata dal bisogno e dalla curiosità, oppure, per chi vuole fare lo psicoanalista, (anche) didattica, finalizzata a scopi professionali e quindi parte fondante dell’iter di formazione.
A un esterno, non addetto ai lavori, potrebbe sembrare che più analisi fa il futuro analista, maggior garanzia di esperienza e salute mentale darà ai pazienti ...
Il tema non è di facile risoluzione, ma viene dibattuto dagli addetti ai lavori con tale esasperante difficoltà (non si trova mai una soluzione minimamente condivisibile), da chiedersi se il problema vero non stia nell’impossibilità di rinunciare a una ‘rendita di posizione’ in tutti i sensi.
Io credo che l’analisi personale sia un’esperienza necessaria per diventare analisti, (l’analisi prima di tutto è un’esperienza che non ha niente a che vedere con la sola conoscenza). Tuttavia, dal momento che una certa autenticità è la radice della qualità della vita e della professione , un trattamento non chiesto dal paziente per sofferenza, ma ‘imposto’ al paziente/futuro analista per fini professionali, con una scelta ‘obbligata’ del curante all’interno dell’istituzione di formazione; e inoltre un trattamento inquinato dall’idea che esista un’analisi didattica migliore delle altre, poiché condotta da psicoanalisti più in alto nella scala gerarchica si presenta già così minato in partenza, che l’unica soluzione possibile sembra essere la totale de-istituzionalizzazione dell’analisi.
Ogni trattamento analitico va condotto in un ambiente protetto, fuori da ogni sguardo esterno e da ogni ingerenza, quindi in ambiente non istituzionale!
A cavallo tra il 2010 e il 2011 prende corpo all’interno della SPI un intensissimo, appassionatissimo, partecipatissimo dibattito on online attorno a questo tema. (Dibattiti SPI online a cura di F. Carnaroli, www. SPI web: SULLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL’ART. 2 DEL REGOLAMENTO SPI).
A Milano, il 7 maggio 2011, al convegno Autorità e leggi nelle culture post-paternaliste, presento: "L'Istituzione Psicoanalitica tra cambiamento e tradizione paternalistica".
A Bologna, il 28 maggio 2011, con M. Bezoari, R. Jaffè, A. Usuelli, al
Convegno a Seminari Multipli della Società Psicoanalitica Italiana, presentiamo:
“L’analisi didattica, Note storiche, Riflessioni critiche, Prospettive attuali e future”.
II 16 settembre 2011, una data storica per la piccola società di psicoanalisi italiana, l’emendamento n. 2, un emendamento assolutamente imperfetto che vuole essere solo il primo passo verso una separazione dell’analisi personale (dei futuri analisti) dal training e dall’istituto di training, nella speranza di de- istituzionalizzare nel tempo l’analisi, è approvato a larga maggioranza. Vale a dire che l’idea di fare/dover fare un’analisi didattica a questo punto dovrebbe proprio cominciare a tramontare. Vota quasi l’ottanta per cento degli aventi diritto, questo è il fatto straordinario.
Dal 1 febbraio al 14 aprile 2012, segue, in internet, ma nella sezione privata della SPI, un altro dibattito teorico-clinico fiume:
Istituzione, Gruppi, Alleanze Inconsce (a cura di Francesco Carnaroli e Claudia Peregrini),
a partire da una relazione di C. Peregrini e M.Ramella: “Silenzio e conformismo: patti denegativi e alleanze inconsce nell’attuale società psicoanalitica”.
Perché ne parlo
Parlo diffusamente di tutto questo anche per dire l’estrema vivacità (sale della vita!) di quegli anni istituzionali, anni di rara autentica appassionata partecipazione collettiva. D’altra parte, senza passione verità e autenticità non si da alcuna ‘cura’ psicoanalitica e vivere (in generale e in particolare all’interno dell’istituzione) diventa il solito gioco opaco, sempre uguale, dove le regole del potere e del conformismo, spesso contrabbandate, rendono sterile ogni partecipazione. Rimaniamo morti.
Alla fine del 2014 mi dimetto dalla Società di Psicoanalisi Italiana.
Alla fine del 2020, con la nuova presidenza di Sarantis Thanopulos (per il rinnovamento SPI). mi viene chiesto di rientrare nella Società di Psicoanalisi Italiana.
Qui sotto, i miei figli.
Ilaria Stucchi è medico pediatra in Patologia Neonatale all’Ospedale dei Bambini ‘Vittore Buzzi’ di Milano. (Lavora principalmente con i grandi immaturi)
Andrea Stucchi (l’ultimo a destra, col suo team in Africa, Tanzania) è avvocato di diritto inglese e consulente legale in materia di partenariato pubblico privato presso la Banca Mondiale.
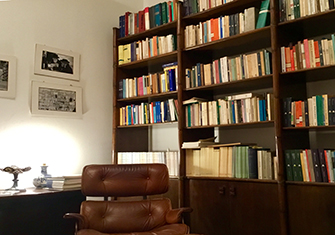


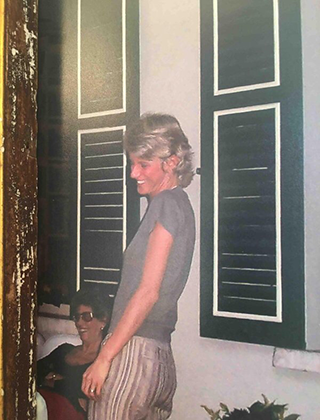



 English
English Français
Français