La clinica
Abstract
Due lingue insieme. Le singole lingue, nello specifico la lingua della psicoanalisi e la medica, se rimangono vive, ognuna con la sua specificità, non svendendosi, possono imparare ad aiutarsi moltissimo, ad arricchirsi e a far capire meglio che il problema è appunto di natura epistemologica, -di conoscenza-, non ontologico. Le lingue, accostate, tra consonanze e dissonanze, si definiscono meglio e aiutano a comprendere il rimando tra universale e singolare.
(L’analisi oggi è terminata.)
(La paziente ha autorizzato la pubblicazione.)
Premessa al caso clinico
Il problema visto dal punto di vista dei linguaggi.
Proviamo allora ad affrontare il problema Mente Corpo dal punto di vista dei due linguaggi, che, per tradizione e privilegio, si occupano delle due facce del problema mente corpo. I linguaggi psicologici e il linguaggio medico, i quali studiano la mente a partire dall’esperienza del corpo vissuto e studiano il corpo cosiddetto biologico. Proviamo adesso a precisare (in modo rigoroso) quale è, o quale può essere il rapporto che ciascun linguaggio intrattiene con il proprio oggetto specifico. Appunto, la mente e il corpo, intesi come effetto di rispecchiamento l’una dell’altro.
Esisterebbe una psiche, per come noi oggi la intendiamo, senza la psicologia che la studia, ne definisce i confini e la natura, la forma e le dimensioni? Se eliminassimo la tradizione degli studi psicologici, saremmo semplicemente nell’impossibilità di vedere la psiche, in quanto dimensione psicologica della vita. La riprova è che nella nostra cultura arcaica e in molte culture nel mondo non esiste un uomo psicologico e non esiste una scienza psicologica. Non esiste la psiche come oggetto, ossia come fenomeno, per una scienza, nel senso che non esiste una rappresentazione che la pone.
Rimaniamo sicuramente sconcertati quando ci accorgiamo che la stessa cosa è vera per la medicina e per le scienze della vita biologica. Se eliminassimo l’intera tradizione da cui queste scienze sorgono e che, oltre a istituirle, le informa in senso sapienziale, non solo strumentale, tutti i loro apparati d’esame e di ricerca, -perfino i loro oggetti, dal neurone alla cellula, dalla facoltà della vista a quella dell’udito, eccetera-, cesserebbero di esistere.
Prendiamo l’evento sogno.
Il punto è che ciascuna scienza istituisce i propri oggetti, proprio come ci ricorda Galileo (nella natura troviamo quello che mettiamo), altrimenti non sapremmo né cosa cercare, né come cercarlo. Così, il sogno, per ritornare al nostro esempio, lo vediamo, non malgrado, ma proprio attraverso gli apparati della psicoanalisi, dalla metapsicologia al setting.
Voglio dire che il sogno, come sogno psicoanalitico, esiste solo all’interno della psicoanalisi, mentre, in altri luoghi, è tutt’altro, per esempio, un messaggio degli dei. Poi naturalmente esiste il sogno di cui parla la neurofisiologia, che è un’altra tipologia di 'ente', un altro fenomeno, e che, senza la tradizione neurofisiologica, ovviamente non esisterebbe proprio nei termini in cui lo pensa la neurofisiologia.
Il punto, come dicevo, non mi sembra stabilire se è più vero il sogno della psicoanalisi, oppure il sogno della neurofisiologia. Ciascuno ha il suo grado di verità all’interno della pratica che lo istituisce. Il punto è comprendere che il sogno, in quanto tale, al di là di qualunque lettura ne facciamo, psicoanalitica, neurofisiologica, religiosa, mitologica, superstiziosa, dei tarocchi, eccetera, non c’è.
Le due lingue.
Adesso rimane un problema molto importante e delicato da considerare attentamente: come possono (se possono) i due ‘opposti’ linguaggi, medico/neurofisiologico e psicoanalitico, dialogare tra loro?
Torniamo al dialogo tra psicoanalisi e neurofisiologia.
Notoriamente noi concepiamo il dialogo tra le discipline come una pratica dominata dall’ideale della metexis o della hybris guerriera. Le alternative sono due: stabilire un terreno di contatto comune - nei termini di una validazione e di una conferma reciproche-, oppure stabilire il primato, ossia la maggior veridicità, dell’una sull’altra. La seconda versione prende corpo quando per esempio chiediamo alla psicoanalisi di scendere sul terreno della discorsività scientifica positiva, dura.
Le cose stanno veramente così?
Il punto è che entrambe le strategie presuppongono lo stesso gesto. Il gesto per cui esiste la cosa, uguale per tutti, là fuori nel mondo, e noi ne dobbiamo rendere conto, possibilmente, mettendoci d’accordo e stabilendo una volta per tutte quale versione sia la più vera.
In altre parole, il punto è che, qualunque strada si scelga, il modo di pensare resta epistemologicamente identico: l’oggetto di studio e la pratica scientifica che se ne occupa sono e rimangono assolutamente indipendenti. Non solo, entrambe le vie presuppongono come possibile un gesto che, in realtà, riduce l’oggetto indagato a fenomeno epistemologico finito. Una conseguenza, questa, impossibile da sostenere, quando l’oggetto che si studia è la vita, la sessualità, l’inconscio!
La terza versione.
Al di là della validazione reciproca e del fatto di dover stabilire una sorta di primato di una delle due discipline, esiste una terza versione, altrettanto forte. Sostiene che il dialogo tra le diverse discipline è insensato, quindi inutile è la tradizionale posizione psicoanalitica dinanzi al discorso neurofisiologico.
Per molti psicoanalisti, la mediazione tra i due linguaggi, della medicina e della psicoanalisi, è un assurdo epistemologico rischioso per entrambi. Per esempio, secondo loro, non ha senso tradurre un concetto cardine quale la ‘coazione a ripetere’ (la ripetizione incoercibile di vecchie esperienze penose), nella lingua della neurobiologia, ossia in certe regolarità elettriche presenti nel cervello, rilevabili all’elettroencefalogramma.
Il prezzo di una simile operazione, dicono, è appiattire entrambi i riferimenti ai limiti dell’insignificanza teorica[1]. Molto meglio che un silenzio rispettoso eviti imbarazzi ai contendenti.
Ignorare la medicina.
Eppure, ignorare la medicina, e le neuroscienze in particolare, oggi è insensato, ma vorremmo suggerire un’altra via. Quella per cui il gioco delle due lingue e il loro incontro non ha per scopo il sopravvento o la conduzione tra oggetti che non sono identici, né nella realtà e nemmeno nel pensiero, ma ha come scopo permettere a ciascuna delle due discipline di reperire, attraverso l’incontro con l’altra, una migliore e più profonda comprensione di se stessa. Ha come scopo proteggersi dall’illusione (metafisica, universalistica) di possedere tutta la verità della cosa. Il confronto tra medicina e psicoanalisi dovrebbe avvenire proprio nel duplice intento di usare l’altra disciplina per una più profonda rielaborazione della propria architettura concettuale, e per una revisione etica dell’onnipotenza del proprio discorso. Il che andrebbe a tutto vantaggio dell’evento di cui medicina e psicoanalisi, ciascuna a proprio modo, cerca di rendere conto: la vita umana, niente più e niente meno.
Vediamo, anche attraverso la clinica, altri motivi fondamentali che attengono a una modificazione (profonda) del modo di sentire in seduta quando si usano le due lingue.
La clinica.
Quando in seduta ci capita di oscillare tra due letture, sentiamo che qualcosa si perde, mentre qualcos’altro passa, sia in un senso, sia nell’altro, mentre, passando, definisce funzionamenti differenti. Così, noi analisti diventiamo testimoni e partecipi attivi del senso di spaesamento in atto. Si tratta di muoversi via dai cliché interpretativi, avvertendo il movimento delle idee e degli affetti che tendono alla loro struttura ‘materiale’, quasi dissolvendosi in essa, mentre la struttura ‘materiale’ a tratti (lampi) prende vita in rappresentazioni e affetti nuovi.
Un potente fattore terapeutico.
Quando oscilliamo tra territori impensabili con i soli nostri simboli, aiutiamo i nostri pazienti a cominciare a sentire il loro corpo (nominandolo e nominandone i funzionamenti), perché ne ampliamo la consistenza, fondando, insieme, il primo nucleo di un Sé ‘corporeo’ autentico.
Per esempio, parlare al paziente in seduta di una sua perdita, con lingue diverse, dà un effetto di verità maggiore, non perché mette in campo, accanto al mentale, il corporeo inteso come dato concreto, reale, ma perché l’uso di terreni simbolici diversi, fa sperimentare una forte differenza di livello in quanto tale, quindi, un via vai di forze maggiori nei due sensi, una sorta di rimbalzo continuo tra mentale e corporeo.
Sembra di salire in ‘superficie’ e di scendere in ‘profondità, ma non è così. È che stiamo imparando semplicemente ad abitare la differenza di livello in quanto tale: questo ci riempie di sensazioni vive di un ritmo nuovo, attivo. Inoltre, succede che i diversi livelli del discorso, pur rimanendo dotati della loro specifica autonomia, non rimangono drasticamente isolati e pensati solo da curanti diversi.
Un caso clinico
“Uno scrittore così antico quale è Aristotele considerava abbastanza probabile il fatto che i sintomi di una malattia si avvertissero nei sogni (...) Anche gli autori medici, che erano certamente lontani dal credere al valore profetico dei sogni, non hanno messo in dubbio il loro significato di premonitori di malattie”.[2]
Martina
È una venticinquenne lunga, esile, bionda. Fa la modella. Ha girato il mondo per i continui spostamenti del padre. Padre e madre dopo infiniti tira e molla si sono separati qualche anno fa. Martina ha lasciato la sua famiglia a vent’anni, ha studiato, legge molto, ha un buon lavoro, ha qualche amico (gay, dal momento che il suo ambiente lavorativo è per lo più gay), qualche amore con ragazzi difficili.
Inizia con me un’analisi a tre sedute settimanali, ricca di sogni che racconta nei dettagli e interpreta. Nelle fantasie e in qualche sogno all’inizio dell’analisi appaiono i genitori, giovani e infatuati. In un sogno, Martina si vede dietro un vetro, quasi ritirata in una bolla 'autistica', mentre guarda la cinepresa del padre filmare continuamente la madre, che è talmente fusa con la sua immagine idealizzata da non avere posto per loro tre, bambini piccoli, e soprattutto per lei, la cucciola di casa.
Ha una grave forma di colite spastica che si è sempre riacutizzata nei momenti più tesi tra i genitori. Durante un’estate di particolare solitudine viene mandata in un paese straniero presso una famiglia sconosciuta, e la sua colite diventa ulcerosa.
Racconta che l’anno prima di cominciare l’analisi, di ritorno da un lungo viaggio in aereo, ha avuto una grave embolia polmonare, dopo una precedente trombosi a un arto inferiore.
Durante il lungo ricovero, è stata molto male fisicamente ed “è andata in tilt” (I sintomi riferiti sono di angosce e sintomi pre-psicotici).
Penso da medico al legame tra embolia e trombosi. Ne parliamo. In persone predisposte è sufficiente uno stato di immobilità (lungo come il suo viaggio in aereo) e i trombi agli arti possono diventare emboli polmonari.
Parlarne, nominare fatti e sintomi, ci permette di visualizzare un trombo infilato in una gamba, che si muove scivolando verso un polmone, mentre lei è costretta all’immobilità.
La patologia
È al contempo 'concreta', sogno, e metafora.
Martina ha un’idea delle cause, dei legami, diversa dalla mia. Crede nello sviluppo meccanico delle conseguenze. Fa dipendere la sua patologia dalle emozioni in modo diretto, secondo una causalità lineare. Liquida la faccenda dicendo: “è stato lo stress”. Tra i vari fatti circolatori ha da qualche anno il morbo di Raynaud, una mancanza per cause neurovegetative di controllo vasomotorio delle estremità, soprattutto quando fa molto freddo o si provano emozioni poco sopportabili. A un fenomeno di vasocostrizione ne segue uno di vasodilatazione eccessiva, per cui, per esempio, le mani prima diventano bianche e fanno male, poi, rosse, cianotiche, gonfie.
Parlo con Martina del fatto che le cause di questa malattia sono multiple e complesse, (non esiste un’unica causa lineare); le dico che, anche se la ricerca di certi auto-anticorpi in lei è positiva, un’auto-immunità positiva non vuol dire, come lei ha sempre creduto, che il corpo tout court si rivolge contro se stesso. Esiste invece una sorta di forte analogia tra il suo sistema neurovegetativo in grado di regolare poco e il suo carattere. Nel senso che, o si trova controllata, rigida, bloccata, o persa nel vuoto, senza confini, con la sensazione di sfumare, di volare via, come Mary Poppins.
In un buon periodo dell’analisi, che coincide con la fine delle sue terapie mediche e la riduzione del fenomeno di Raynaud, Martina racconta un sogno molto diverso dai suoi soliti, molto meccanico, quasi ‘iperrealista’: dal lettino analitico spunta il dito indice molto ingrandito e visto nei minimi dettagli della mano sinistra di un’amica, fissurato, spaccato in due per il lungo, un’ulcera lunga e profonda. L’amica mette poche gocce di anestetico e non prova dolore. Martina accompagna il racconto con i gesti. Il sogno continua mettendo in scena il suo modo anestetizzato di reagire ai fatti separativi. Per esempio, una farfalla piomba giù in strada, con un volo strampalato, da una finestra di un piano molto alto. Ma in strada c’è un uomo (l’analista?), che la attende e la salva.
Ci chiediamo, in modo un po’ automatico:
“Perché questo sogno proprio adesso che sta bene?”.
Penso con ansia che è solo un sogno, però, talmente strano, talmente diverso dai suoi sogni davvero sognati.”
Cerchiamo prima di tutto, insieme, momenti di non contatto e di non regolazione emotiva in seduta, che possono aver causato quel sogno.
Cerchiamo poi un suo ‘stare male’ nascosto con l’anestetico, la difesa contro le angosce separative e il mondo pulsionale che si sta svegliando.
Penso alla fatica, agli scatti di Martina, che pur procede nel suo percorso; penso agli arresti anche casuali del suo tessuto emotivo-affettivo alle prese con un difficilissimo percorso separativo-individuativo, tra mille stop visibili soprattutto nella dimensione corpo: una colite prima spastica, poi ulcerosa, una trombosi, l’embolia, il morbo di Raynaud...
Naturalmente, parlare in analisi di angosce anestetizzate, perché dolorose a tal punto da far morire, viene facile a tutte e due, mi sembra però che Martina capisca solo in teoria.
C’è comunque qualcosa che non torna, un sogno così diverso dagli altri, da sembrare un pezzetto di realtà. Non basta conoscere le teorie, sapere che forse si tratta di un sogno che preannuncia la crisi psicotica. Di nuovo, la domanda quasi ossessiva, ripetuta ottusamente, come se esistesse in me un imperioso bisogno di dare senso: “Perché proprio adesso?’’.
A questo punto penso che quel sogno sia davvero un sogno grave, indichi che la paziente percepisce il verificarsi in lei di una profonda scissione psichica, una sorta di spaccatura verticale, la spaccatura psicotica in atto.
L’omino che appare in strada in finale e sembra aiutare la farfalla mostrandole come muovere le ali potrebbe essere la comparsa di una parte maniacale di Martina, contro l’angoscia scatenata dal sentimento di ‘spaccarsi’.
Mi trovo poi comunque a considerare con un certo sollievo (difensivo?) che non esiste un peggioramento reale, si tratta solo di un sogno che tenta la prima messa in scena del fatto separativo, con tutte le angosce correlate. Martina al momento non può che rappresentarsi così i distacchi (salti strampalati, buchi, voli, rischi di morire, angosce acute alternate ad anestesie, omini-analisti improbabili che forse la salvano).
Transiti psicotici.
Interviene in seduta una sorta di vuoto totale, che disfa ogni ricerca di senso. La clinica disfa ogni teoria; attraverso il non senso, il vuoto, sembra di poter arrivare alla ‘cosa’, di attraversarla, per approdare a una possibilità, minima, di senso, di ‘vero’ senso. Il vuoto psicotico che si è presentificato nella spaccatura della scissione nel ‘sogno’ -l’ulcera nella pelle del dito dell’amica- ha aperto a un’altra dimensione, un grande spazio vuoto. Non abbiamo definito/capito il buco onirico nel dito, ci è capitato di viverlo.
Si alternano di nuovo in seduta sensazioni di vuoto a sensazioni di claustrofobia, come se tutto a tratti rischiasse di diventare di nuovo una gabbia. Svanire, fluire via in uno spazio troppo aperto, esserci, stare di nuovo (nel troppo chiuso), sentirsi pesanti, soffocare, percepirlo insieme, dirlo, muovendosi poi lontano dalla sensazione del senso ogni volta raggiunto. L’ignoto del corpo, su cui operano transfert e controtransfert e le comunicazioni psicoanalitiche, è un fuori senso, mai raggiungibile.
Mi accorgo che Martina ha bisogno che io riprenda a pensare e a parlarle della gabbia, interpretando.
“La gabbia non è solo la malattia con le sue ricadute, la ripetizione delle ulcere, ma anche l’eventuale mia rigidezza; anche l’obbligo a trovare per forza un senso, nel lavoro analitico, e la delusione, perché si crede di capire e poi si torna a star male; soprattutto è il suo bisogno di me e dell’analisi, intenso e più autentico, e la ribellione per il fatto che adesso riconosce non solo a parole questo bisogno”.
... “L’analisi, con i suoi momenti inevitabili di ‘gabbia’, è lo sforzo necessario per costruire la guarigione, non come lei la intendeva, di colpo, una volta per tutte, ma nel senso di nuove funzioni, un nuovo tessuto di pensieri e emozioni, il collagene della nuova struttura ‘ossea’ che si va formando”...
Mi ritrovo a parlarle molto, a spiegare.
Seguono un paio di mesi di buon lavoro analitico e poi una separazione invernale vissuta da Martina in modo quasi maniacale e liberatorio: va a Roma dove balla con un piccolo gruppo di amici in discoteca per notti intere e fuma di tutto.
Al rientro, compare realmente un’ulcera non profonda, ma molto lunga, che fissura verticalmente l’indice della mano sinistra di Martina.
Attraverso un momento d’incertezza e di spaesamento particolari, con un’unica, dolorosa certezza: i medici prescrivono urgentemente un esame (si chiama capillaroscopia), che evidenzia un netto peggioramento del tessuto del dito.
Con questo esame i medici fanno diagnosi di sclerodermia, o, meglio, di una tendenza alla malattia, un pattern sclerodermico (la sclerodermia è una malattia del sistema immunitario a livello del collagene, che ingabbia progressivamente i tessuti, rendendo rigidi, amimici).
Ne parliamo a più riprese in seduta. Proprio nei termini medici.
Mi ritrovo a pensare alla Sclerodermia come a una delle gabbie di Martina: la gabbia corporea per eccellenza.
Il dato concreto dell’ulcera-buco, accompagnato da una diagnosi e una prognosi medica adesso abbastanza negative, mi stimolano a spingermi, proprio come se dovessi fare un forte salto, fisico e immaginativo, verso l’alto, via dal ‘pavimento’ dei cosiddetti dati concreti, verso il ‘soffitto’ dei dati astratti, i nostri simboli abituali. Senza quel pavimento di dati ‘concreti’ (letti dalla medicina), non avrei potuto neppure immaginare il salto.
Le mie considerazioni.
Ieri pensavo che in analisi si potesse ‘volare’ grazie alle teorie - il soffitto dei nostri simboli- e al contro-transfert, oggi ho bisogno di indugiare a lungo sul ‘pavimento dei dati concreti’, universali, che non vogliono dire niente nella nostra lingua psicoanalitica, non rimandano a niente. Ho bisogno di oscillare tra i miei simboli e quei simboli usati dalla medicina (che sono tra l'altro più adatti a parlare di corpo).
Si sviluppa così nel corso delle sedute un linguaggio stranamente analogico (la stretta nella morsa della nostra gabbia diadica è la tendenza (concomitante) alla sclerodermia e viceversa. Nessuna interpretazione simbolica della patologia sclerodermica, nessuna correlazione individuata tra patologia organica e situazione diadica, solo momenti (vissuti insieme) di forte analogia tra le due lingue, come se le due lingue parlassero quasi della stessa cosa, come se alludessero a una quasi identità tra corporeo e mentale. Questo linguaggio doppio opera come potente modulatore delle sensazioni nei momenti più caotici, dà ossatura al tessuto emotivo, lenisce la colpa senza falsificare l’intensità dei deficit e dei conflitti.
Credo che un’analisi condotta tenendo conto dei dati che per abitudine riteniamo ‘concreti’ e dei fatti (ovviamente si tratta sempre di fatti letti tra due persone, il paziente e il curante) abbia una maggiore correttezza etica.
Sento che, in questo modo, con Martina, il salto via dalla gabbia, non solo la ‘sclerodermica’, abbia più possibilità di riuscire.
Il dito fissurato, per la coppia analitica, adesso può diventare metafora: quasi una nascita, che lascia trasparire, sotto, la gabbia sclerodermica. Una nascita fuori dalla gabbia, che rimane però impregnata di paura per il segnale di peggioramento evidenziato dalla medicina.
Penso ai due poli opposti che per un momento coincidono: il male (ventilato) dell’ingabbiamento corporeo per sempre coincide con il grande potenziale di vita, il salto via dalla gabbia della diade, dal collasso nel corpo materno.
Cerco di mettere insieme l’ulcera reale del dito, il buco, il vuoto doloroso e concreto -un fuori senso per eccellenza-, con l’ulcera ammorbidita dal senso della simbolizzazione.
Le dico che il buco evoca al contempo una forma vitale, porta cioè alla luce e mi fa vedere alcuni aspetti dell’esperienza globalmente vissuta da Martina, tracce di forme vitali sperimentate e custodite nella memoria.
Le parlo del buco-dinamica vitali[3], come finestra sull’esperienza (fenomenica (ri)costruita:
“Fare e subire buchi tutta la vita finché il corpo si buca proprio: un buchino in un indice gonfio. L’esperienza del buco accade ora e qui ed è proprio reale: è nella sua natura non poter essere né pensata né espressa a parole mentre è in corso... È nella natura del buco soltanto essere... un vuoto, l’assenza”.
Adesso possiamo parlare e dire insieme che sulla base dei mille buchi soggettivo- oggettivi patiti finora, finalmente si è formato il Buco, il quale, riassumendo tutti i precedenti, la lascia forse come la farfalla che tante volte, da bambina, aveva creduto di essere, realmente libera dalla forma di crisalide.
È il primo tentativo forte di uscire dalla gabbia (anche la sclerodermica).
Le ipotesi tradizionali.
Questa giovane donna -un vero caso psicosomatico- aveva una scarsa mentalizzazione e quindi somatizzava moltissimo.
Oppure, questa donna era afflitta da un misto di deficit e di conflitti inconsci che si traducevano nel corpo, sempre malato. Quindi la sua patologia organica aveva una forte base mentale
La mia ipotesi
Non c’è, non troviamo in natura, alcuna base biologica che spieghi i fenomeni mentali, né alcuna base mentale che spieghi i fenomeni somatici, semplicemente perché non esiste alcuna base, né per i fenomeni mentali né per quelli organici. E non esiste neppure alcuna malattia psicosomatica[4], perché nessuna malattia è solo psichica o solo somatica. E non esiste niente in natura, per così dire staccato da noi. Esiste solo l’incontro tra noi, le nostre discipline con i loro strumenti, e ciò che crediamo essere gli oggetti (In questo caso le patologie), che viene di volta in volta nominato. E siccome non possiamo che nominare in modo distinto, consecutivo, sembra che gli oggetti nominati esistano per davvero e separati gli uni dagli altri. Secondo gli strumenti di cui ci dotiamo per osservarla, definiamo la patologia in questione come organica o psichica.
Tutto questo naturalmente non vuol dire che, se diagnostichiamo malattie ‘organiche’ in cui si deve intervenire, per esempio, chirurgicamente, queste malattie siano per così dire solo ideali, frutto della nostra nominazione: le malattie 'esistono', eccome, ma noi possiamo vederle, diagnosticarle, solo grazie alle nostre teorie e ai nostri strumenti, tra i quali la lingua specifica. Esse appaiono all'interno della lingua specifica con cui le nominiamo, al di fuori, non esistono.
Martina sta facendo un percorso analitico per acquisire una vita (la sua) e una competenza pulsionale, una ‘libertà’ psichica, cioè una certa plasticità, tale da restituire mobilità agli investimenti; in altri termini, un tessuto emotivo-affettivo-cognitivo (una mentalizzazione) più ricco, duttile e variabile. All’inizio, Martina sentiva confusamente, distingueva poco le sensazioni e aveva emozioni caotiche; ragionava, sognava, ma in modo meccanico, auto interpretandosi quasi tutto, però non senza una vena di ironia...
Non ha senso cercare per la sua complessa patologia somatica ragioni mentali, a meno di non riferirsi al fatto che, nell’eziopatogenesi, la quale sempre si mescola in un continuum all’espressività (come in qualunque malattia), è implicato in vario modo il tessuto emotivo- cognitivo. Viceversa ha senso cercare un rimando, un rimbalzo continuo tra alcuni fenomeni interpretati dalla medicina e alcuni eventi interpretati dalla psicoanalisi; ha senso leggerli simultaneamente e continuamente, senza soluzione di continuità. Per esempio, mi sembra che il formarsi del tessuto pre-sclerodermico nel dito sia il momento della massima messa in tensione della gabbia diadica (ricordiamoci che stiamo immaginando di
camminare su un corpo sferico, o di srotolare un dipinto a rotolo).
La gabbia para-autistica, con cui Martina si è protetta a lungo, e quella della compulsione ad agire, durante le separazioni; la gabbia analitica, che la protegge “salvandola, ma da cui a tratti vuole fuggire” suonano in quel momento come il rimando della gabbia del pattern sclerodermico, che si presenta a un certo punto del trattamento nella sua doppia veste, come spia del male assoluto (sarebbe un vero guaio se diventasse una sclerodermia grave), e come spinta che stimola la coppia analitica al salto via dalle ripetizioni imbriglianti, verso libertà nuove. Mentre allerta i medici a controlli e cure più ‘efficaci’.
Unità chiasmatiche.
Più che di rimandi, poi, provando a superare ogni traccia di dualismo mente corpo (che usiamo per nominare), penso ai livelli d’identità e di esistenza, che non si possono neppure più localizzare, perché non si trovano qui piuttosto che là, non hanno un locus, una collocazione spazio temporale, si muovono in continuazione, prendono forme che continuamente si dissolvono in zone di indiscernibilità, recidendo tutte le connessioni precedenti. Sono ‘quasi identità’ corpo mente, unità chiasmatiche all’interno di uno psicosoma puramente relazionale, che esiste solo come pattern relazionale, appunto, il quale naturalmente acquista esistenza per così dire sostanziale e materiale quando ci dotiamo di certi strumenti e linguaggi.
Martina esiste, la vedo, la sento, parlo con lei, il suo buco nell’indice della mano sinistra è ben reale, ha una sua presenza, una sua forza. La sua realtà in ogni momento è il mio nuovo punto di partenza. Quando si presenta in seduta con il buco nell’indice sinistro da cui ‘traspare’ il tessuto pre-sclerodermico crea in me ‘azioni e reazioni’ che ci muovono via dalle strutture ingabbianti, in un percorso all’infinito, a cercare -ciò che non troveremo-
Comunque, a cercare. La salvezza sta nel fare esperienza di questa ricerca: oggi, quattro anni dopo l’inizio dell’analisi, non c’è traccia della vecchia sintomatologia organica (quiescente?) e Martina si sta un po’ innamorando.
Ma, come ben sappiamo, sintomi e patologia servono anche a proteggere da sentimenti intollerabili di perdita, anche per questo, abbandonare la sofferenza è un lungo, tortuoso cammino, come dice Freud in Analisi terminabile e interminabile.
Dicevo che a questo punto dell’analisi di Martina è in corso un processo di natura tale da non essere né localizzabile, né categorizzabile. È solo un modo, un’entità relazionale, immerso in un continuum esperibile dalla coppia analitica incamminata sull’ideale corpo sferico, o tappeto a rotolo.

Immagine 1: Nastro di Möbius
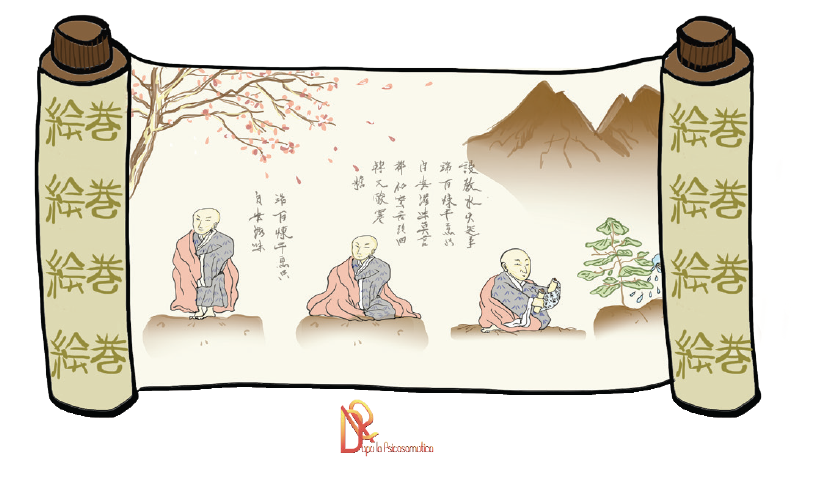
Immagine 2: Dipinto a rotolo
[1] Merciai e Cannella segnalano a questo riguardo il pericolo del collasso, nel loro interessante ed esaustivo libro “Psicoanalisi nelle terre di confine” (2009, p.15), quando per esempio riportano (criticandolo) un frammento dell'International Journal of Psychoanalysis, firmato da David Olds e Arnold M. Cooper (1997, 78, 2: 223): “[L’incontro con le neuroscienze è necessario] per evitare alcuni grossolani errori di concettualizzazione del passato, come interpretare come masochistiche le difficoltà di organizzazione di un paziente con un disturbo di deficit dell’attenzione o come considerare il disturbo ossessivo-compulsivo come unicamente derivato da problematiche anali o edipiche”.
Non si tratta affatto di considerare le difficoltà di un paziente solo come masochistiche o solo come disturbo di deficit dell’attenzione! Olds e Cooper hanno un modo di argomentare che sfiora l’assurdo. Non si tratta neppure di cercare conferme esasperate al tentativo biologico di Freud, e giustamente Kandel (2012) lo sottolinea, criticando gli eccessi di neuropsicoanalisti come Solms, che vede ogni elemento della concettualizzazione freudiana perfettamente convalidato dalle attuali neuroscienze.
[2] Freud S. 1900, L’interpretazione dei sogni, O.S.F. vol.3.
[3] Stern D.N., (2010) “Le forme vitali”, Milano: R. Cortina, 2011
[4] Trombini G.& Baldoni G. (1999) “Psicosomatica”, Bologna: Il Mulino, 1999
Tel: 00393397469709
E-Mail: c_peregrini@yahoo.it


 English
English Français
Français